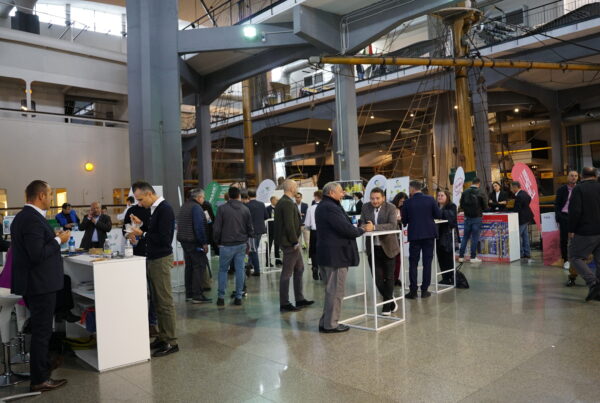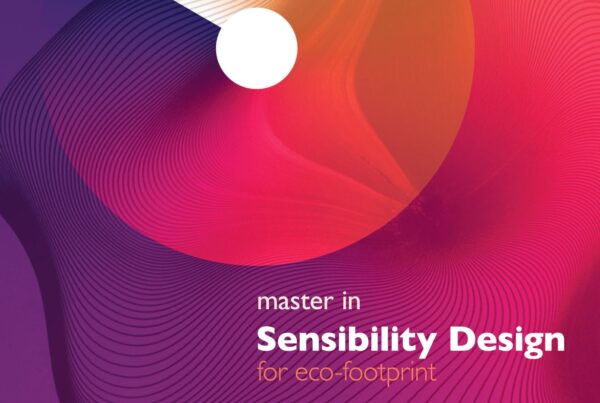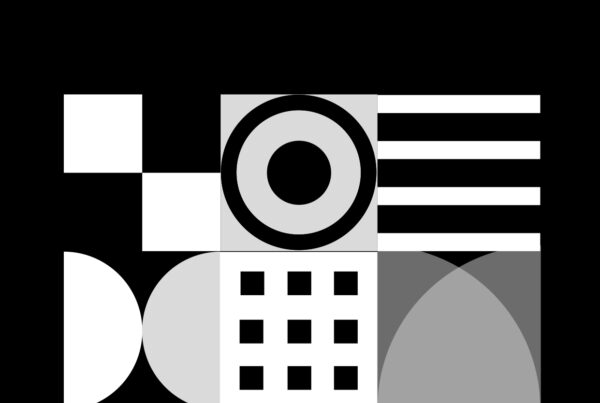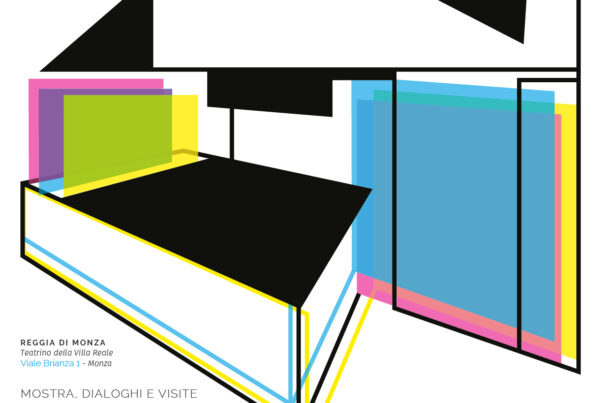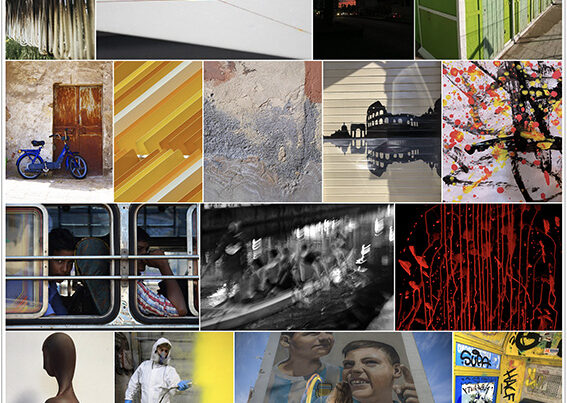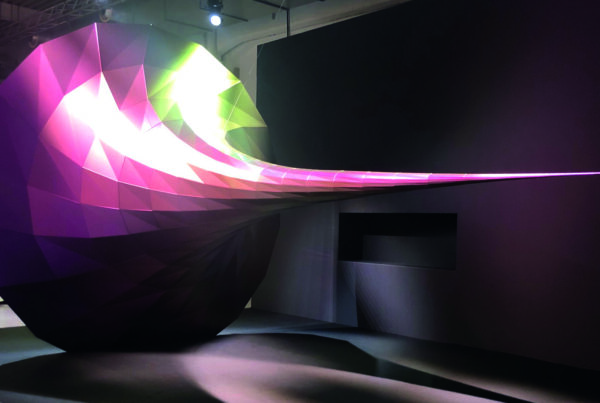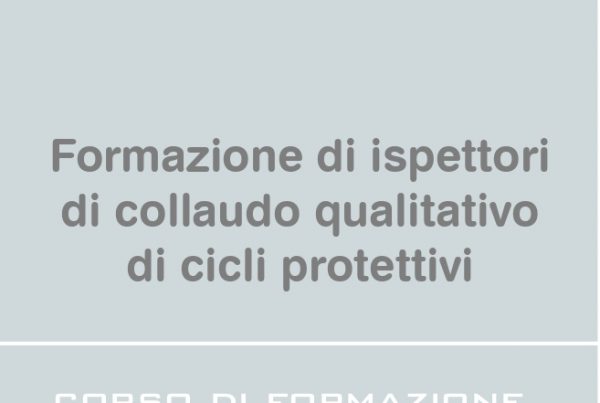Nel mese di marzo, nei primi giorni del lockdown, scrissi l’editoriale “Cigni Neri e Notti Bianche”, che ha fatto il giro di mezzo mondo tradotto in 4 lingue, perché evidentemente coglieva in anticipo alcuni aspetti di quello che stava per accadere, offrendo una chiave di lettura che a quel tempo molti considerarono originale. Sono trascorsi quasi 10 mesi e quello che avevo scritto è ancora valido, e mi piace l’idea di attualizzarlo, perché sono accadute e cambiate tante cose in questo breve lasso di tempo: sono cambiate dentro e intorno a noi. Erano i tempi dello shock sociale, dell’ “#andràtuttobene”, dei concerti sui balconi e sui tetti e del cooking tra un pianerottolo e l’altro, esperimenti belli di social teambulding pieni di adrenalina che permetteva di affrontare le notti bianche, nell’ambivalenza tra sgomento e speranza.


Nel frattempo sono spuntati decine e decine di esperti di resilienza (mentre uno di quelli veri e più grandi, Salvatore Maddi, se n’è andato qualche giorno fa – onore, Maestro), ed altrettanti di neuroscienze applicate dopo aver letto qualche libro al volo, mentre Giacomo Rizzolatti continua a lavorare in silenzio nel suo laboratorio. Follower entusiasti dello smart working che fino a un anno fa se gli chiedevi una riunione online ti davano del matto o asociale (a proposito, lo sapete che lo “smart working” si chiama così solo in Italia e che altrove si chiama lavoro agile o lavoro flessibile, e che in moltissime organizzazioni si fa telelavoro e non lavoro agile?).
Ma soprattutto le Notti Bianche piene di adrenalina sono diventate Notti Stanche piene di cortisolo, è aumentato il nervosismo sociale, nonostante il continuo richiamo all’Empatia sociale; e il Cigno Nero se la ride di gusto. Con Empatia, si sa, intendiamo generalmente la capacità di comprendere ed immedesimarci negli stati d’animo e nelle emozioni altrui, di farne tesoro e in qualche modo di sentirli propri, di tenerne realmente conto nelle nostre azioni e reazioni insomma, come si dice, di metterci nei panni o di “camminare nelle scarpe di qualcun altro”.
L’Empatia ha un grande successo, identifica oggi più che mai tutto ciò che ci può essere di buono, compassionevole e collaborativo nelle relazioni tra persone, quello “stare insieme” costruttivo che dovrebbe aiutarci a vincere il Cigno Nero che è ancora lì che ci condiziona con il suo fascino maligno. Dovrebbe essere quindi l’elemento “buono”- per quanto altamente complesso in ciò che lo determina e nelle sue manifestazioni – alla base della costruzione di quelle reti di sostegno attive che tanto incidono sulla resilienza.
Ma voi la vedete, la sentite davvero tutta questa Empatia in giro? Facciamo un esperimento/gioco (prendetelo come tale, in questi mesi non sono diventato un neuroscienziato, anche se rinascessi ora mi piacerebbe diventarlo, uno di quelli bravi). Se vi chiedessero di donare un euro per salvare questo magnifico orso polare che pare evidentemente in difficoltà per via delle tragedie in atto a causa dei cambiamenti climatici, e magari foste insieme a vostro figlio o figlia in tenera età che tanto ama gli orsetti, lo fareste?
Io sì, lo farei, proverei una forte empatia per questo essere vivente in difficoltà, anche se non è un essere umano. Ma se si allargasse il campo dell’immagine e si vedesse che davanti all’orso ci fosse un ampio e spesso strato di banchisa sulla quale scorrazzare, e che l’orso è probabilmente salito sul cumulo di ghiaccio per giocare, semplicemente per divertirsi, lo fareste lo stesso?
Probabilmente no, almeno io forse no.
Ancora: se sentiste la notizia che una persona che si è arricchita con una fiorente attività e che ha evaso le tasse per anni, si trova sul lastrico, “non sa come fare” ad andare avanti, e ottiene aiuti, bonus, esenzioni, e altre forme di sostegno, provereste empatia per quella persona? Io, sinceramente, no.
Ancora, provereste empatia per l’imprenditore che parcheggia l’auto di lusso appena consegnata davanti all’azienda avendo le persone in cassa integrazione? Io, sinceramente, no.
Provate empatia per chi se ne fotte di mettersi le mascherine e si mette in assembramento (altra parola che ha assunto “epic meaning” nella narrazione quotidiana di questi tempi disastrati) per farsi l’aperitivo a tutti i costi costringendo gli altri a girare alla larga? Io al massimo provo comprensione per la voglia di tornare a stare insieme, per la voglia di socialità sottratta, ma empatia no, per nulla. Perché?
Perché l’empatia è selettiva, eccome se lo è. Ed ha anche un lato egoistico.
Tania Singer, una brillante neuro scienziata francotedesca che lavora con il suo team al Social Neuroscience Lab della Max Plank Society di Berlino ha dimostrato tramite un esperimento che le risposte neurali empatiche si manifestano con maggiore forza ed evidenza nei confronti di chi ha dimostrato comportamenti socialmente corretti (non fregare, attenersi alle regole, non barare, ecc.), rispetto a coloro che pur trovandosi in difficoltà come gli altri, si dimostrano scorretti nei comportamenti sociali. E ciò accade con maggiore evidenza negli uomini che nelle donne, che sicuramente, lo si sa non da ora, Interessante vero? Una bella chiave di lettura di quanto vediamo intorno a noi, e proviamo. Ma c’è di più, siamo più empatici nei confronti delle persone che conosciamo e molto meno nei confronti degli sconosciuti, anche se sono più sofferenti di coloro che conosciamo. Vale a dire che il cerchio dell’empatia si restringe: bisogna che sentiamo la sofferenza o il disagio di qualcuno che sta vicino a noi per accorgerci davvero di cosa è la “nostra” empatia e, viceversa, di quella altrui nei nostri confronti, se siamo noi ad essere in sofferenza. Se si ammala di COVID19 un tuo parente o amico allora soffri anche tu, ma quando ti dicono che anche oggi sono morte 600-700 persone provi dispiacere, ma non la stessa empatia, sono storie lontane dalla tua cerchia, nonostante il dato sia terribile in assoluto.

Bisogna che sentiamo la sofferenza o il disagio di qualcuno che sta vicino a noi per accorgerci davvero di cosa è la “nostra” empatia e, viceversa, di quella altrui nei nostri confronti, se siamo noi ad essere in sofferenza.
Molti anni fa ero in Etiopia in un grande cantiere dell’azienda in cui lavoravo ai tempi, e ricordo che fuori dal cantiere c’erano centinaia di bambini “assembrati” che cercavano un po’ di cibo di avanzo dalla mensa del cantiere, dove i cuochi facevano un ottimo lavoro e si mangiava come pretendevano i nostri operai, quadri e dirigenti. Io non avevo mai visto una cosa del genere (solo nei filmati delle onlus) e mi sentivo fortemente a disagio, e chiesi al Capo Campo se potevamo fare qualcosa per quei bambini. La sua risposta fu per me al momento agghiacciante: “non possiamo farlo, perché se lo facessimo domani ce ne sarebbero mille in più e dopodomani altri mille, e non possiamo aiutarli tutti, anzi peggioreremmo le cose: se vuoi veramente fare qualcosa scegline uno, bambino o bambina che sia, ma uno solo, e adottalo, concentrati su di lui o di lei, e lo salverai, non tutti, ma uno”. Mi ribellai interiormente, ma man mano che passavano i giorni capii mio malgrado che, per quanto ingiusto, fosse corretto.
Avevo appena scoperto la differenza tra l’empatia emotiva (che ti porta a concentrarti sui disagi più grandi, “di tutti”), e l’empatia cognitiva (ragionare su cosa puoi fare veramente), sapendo che in noi convivono entrambe, ma l’una prevale sull’altra in contesti e situazioni differenti. Qualche anno dopo scoprii che la pensava così anche Madre Teresa di Calcutta, una che dell’empatia aveva fatto la sua più grande missione.
Con la componente emotiva dell’empatia li vorrei salvare tutti, con quella cognitiva faccio il meglio che posso e ne salvo il più possibile, uno alla volta. Uno su mille ce la fa, con il nostro aiuto però. E gli altri? Devono sperare di entrare nella cerchia empatica stretta di qualcuno che li conosce, devono avere la fortuna di uscire dall’ “anonimato empatico”, e noi possiamo aiutarli. Non lo facciamo certamente con la Reattanza che vediamo montare in questi giorni, che altro non è che una forma disempatica sociale che molti individui mettono in atto quando sentono minacciata la propria libertà di agire, rifiutando, anche platealmente, prescrizioni che ritengono personalmente illegittime o immotivate.
Tutto ciò può portare addirittura a comportamenti autolesionistici, nel senso a intraprendere anche azioni che vanno contro il proprio interesse (come prendersi il COVID19, ad esempio): l’unica cosa che conta è opporre resistenza a qualunque cosa o a chiunque metta in discussione il proprio sentimento di libertà soggettiva (nessuno può impedirmi di fare quello che voglio, oltre una certa soglia autodeterminata).
La Reattanza non va sottovalutata, ora men che mai, trattandola come una forma di mera ignoranza (negazionisti, complottisti, antivaccinisti, ecc.), ma come un vero e proprio fenomeno psicologico di disagio di massa di matrice disempatica, che a livello individuale produce indignazione, rifiuto e rabbia, mentre a livello collettivo può naturalmente trasformarsi in violenza, che paradossalmente ha al suo interno una forma di empatia emotiva di gruppo. Non c’è bisogno di scomodare i classici della sociologia delle masse per dimostrarlo. Sono certo che tra i “reattanti” ci sono persone che hanno perso qualche persona cara nella pandemia, e nei confronti di questa avranno provato sentimenti profondi di empatia, perché solo chi ti è vicino t’interessa veramente. E allora troviamoci in tanti a fare reattanza, chissenefrega, facciamo casino.
Funziona così: anche quando le notti sono stanche la risposta rimane la resilienza, quella vera.
E così le nostre notti bianche di qualche mese fa ora sono diventate stanche, l’ “#andràtuttobene” per molti è stato sostituito da lisergìe distopiche, alimentate dagli scenari fantascientifici dei negozi chiusi, degli spritz proibiti, delle intermittenze sociali, dei centri commerciali dove i negozi sono chiusi se non gli alimentari con gli altri reparti sbarrati, ma con la musica che continua ad andare come prima ed in eterno, in atmosfere che ricordano gli scenari di Walle & Eve, con l’aspettativa di trovare Jena Plissken alla cassa, facendo prevalere la narrazione di un futuro altamente negativo invece dell’utopia di una crescita continua ed esponenziale.
Per gli ottimisti, quelli veri, dotati di realismo, c’è molto lavoro da fare: aiutare a comprendere che è un momento drammatico della nostra esistenza, ma un momento che passerà, che costerà, che il Cigno Nero di turno non si è ancora calmato, ma che ci sarà un dopo, per forza di cose differente, che richiederà lo sforzo empatico dei migliori. Perciò, imprenditori, manager, persone resilienti, non abbandonate le vostre filiere empatiche, ma curatele, nutritele ora più che mai, perché l’empatia ha anche un fondamento di reciprocità. Curando alcune filiere empatiche, ne avrete in cambio empatia, e ne costruirete altre di inaspettate.
Non abbandonate i vostri partner più stretti, chi vi è stato vicino e corretto con voi quando le cose andavano “normalmente”, curate le vostre reti empatiche come se fossero l’ultimo panda esistente, e ne troverete delle altre. Sono e saranno le vostre reti di sostegno, nei momenti più difficili.
Rifletteteci.